Menzogna, verità, invenzione o ironia?
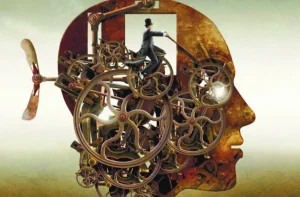 Viviamo in un mondo di narrazioni. Ormai tutto è narrazione. Un disegno, un sospetto, un’ipotesi, un paradosso, un’ossessione: qualsiasi spunto dia forma a insicurezze, diffidenze, paure, dubbi del nostro tempo. Ancor più quando si presentano fenomeni esclusivi che smantellano le nostre presunte certezze. Sprofondati nella nostra inadeguatezza nel trovare spiegazioni e soluzioni a tutto ci abbandoniamo a vari deliri giustificativi e compensatori. Tanto che le narrazioni più contagiose si rivelano proprio quelle mistificanti, che si innestano su avvenimenti emergenziali e gemmano una fioritura di vivaci teorie più o meno farneticanti.
Viviamo in un mondo di narrazioni. Ormai tutto è narrazione. Un disegno, un sospetto, un’ipotesi, un paradosso, un’ossessione: qualsiasi spunto dia forma a insicurezze, diffidenze, paure, dubbi del nostro tempo. Ancor più quando si presentano fenomeni esclusivi che smantellano le nostre presunte certezze. Sprofondati nella nostra inadeguatezza nel trovare spiegazioni e soluzioni a tutto ci abbandoniamo a vari deliri giustificativi e compensatori. Tanto che le narrazioni più contagiose si rivelano proprio quelle mistificanti, che si innestano su avvenimenti emergenziali e gemmano una fioritura di vivaci teorie più o meno farneticanti.
Una pandemia planetaria senza precedenti nella storia e una guerra potenzialmente atomica nel cuore dell’Europa, nella loro inedita combinazione strettamente consecutiva, hanno scatenato una produzione esuberante di teorie del complotto, alimentata ancor più dai sistemi di interconnessione globale. Al punto da produrre un vero salto generazionale anche nell’ideazione di tali teorie. Sono ormai folklore la frode dello sbarco sulla luna, le scie velenose degli aerei ad alta quota, le versioni di una terra piatta oppure cava, a fronte di interpretazioni assai più visionarie come le strategie pandemiche di invasioni militari, i controlli egemonici di fantomatici deep state, i catastrofici effetti di manipolazioni vaccinali, le irresistibili ascese di dittature sanitarie. Cui si aggiungono a ruota i temibili disegni di un impero panrusso e le devastanti ingerenze di una sovranità occidentale.
A fronte tuttavia di questa floridezza di pensiero, amplificata da una risonanza globale di interpretazioni fuorvianti, controinformazioni e virulente fake news – in cui non si crede più a nulla proprio perché si è creduto già a tutto – l’unico modo di narrare per riscattare una nuova credibilità sembra essere quello di appellarsi non all’attuale realtà delle cose, che nessuno sa più quale è, ma a quella già accaduta, ancor più se vissuta in diretta, conclamata dai fatti e certificata dai documenti.
 Si finisce allora col narrare esperienze comuni, vicende ordinarie, familiari accidenti, minimali questioni, sprofondando nella totale vacuità di proprie o altrui vite, desolantemente irrilevanti. Con l’aggravante di ignorare che vi possano essere ben altre realtà assai più degne di nota e di presumere che la propria possa avere una portata più ampia della sua sfinente autoreferenza. Si refertano storie che sono la copia esatta della realtà, si narra solo ciò che è vero e non ciò che conta, con l’unico intento che non possa essere messo in dubbio, a fronte di tutto ciò che non è provato e dunque può essere ritenuto falso.
Si finisce allora col narrare esperienze comuni, vicende ordinarie, familiari accidenti, minimali questioni, sprofondando nella totale vacuità di proprie o altrui vite, desolantemente irrilevanti. Con l’aggravante di ignorare che vi possano essere ben altre realtà assai più degne di nota e di presumere che la propria possa avere una portata più ampia della sua sfinente autoreferenza. Si refertano storie che sono la copia esatta della realtà, si narra solo ciò che è vero e non ciò che conta, con l’unico intento che non possa essere messo in dubbio, a fronte di tutto ciò che non è provato e dunque può essere ritenuto falso.
Cosicché si perde l’unica dimensione che avrebbe senso nel narrare e che valica l’asfittica dicotomia vero/falso – attinente ad altri generi di espressione – ovvero quella dell’invenzione: più autentica della realtà, più illusoria della menzogna. Una narrazione che crea una dimensione simbolica e non speculare, che genera una realtà metaforica e non certificata, che rappresenta un mondo emblematico e non riproduce il puro esistente. L’unico modo per tradurre il particolare in universale e creare altri mondi possibili, quando non impossibili, che fanno intendere molto più a fondo quelli reali.
Punta di diamante dell’invenzione è infine l’ironia, ovvero quella massima distanza che si può mettere tra sé stessi e le cose: scacco decisivo alla menzogna, antidoto definitivo all’autoreferenza, chiave essenziale di rivelazione proprio perché allusa e non diretta, che smentisce, smaschera e deride tutti gli illusori assoluti, i costrutti fallaci di cui nutriamo le nostre esistenze. Picco dell’ingegno l’ironia genera invenzione e stimola riflessione, alimenta le scelte di stile e raffina il gusto della scrittura.
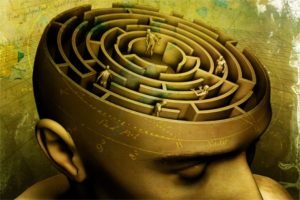 Per questo ritengo che il miglior modo di parlare di narrazioni sia quello narrativo e non saggistico, sia quello creativo e non speculativo, perché se quest’ultimo può spiegare più a fondo le cose, analizzandone rapporti e dinamiche, l’altro le può direttamente mostrare attraverso modulazioni di generi e stili, intuizioni e ironia.
Per questo ritengo che il miglior modo di parlare di narrazioni sia quello narrativo e non saggistico, sia quello creativo e non speculativo, perché se quest’ultimo può spiegare più a fondo le cose, analizzandone rapporti e dinamiche, l’altro le può direttamente mostrare attraverso modulazioni di generi e stili, intuizioni e ironia.
Così nasce questa raccolta di scritti divisa in tre parti. La prima è un omaggio al teatro e alle sue infinite potenzialità di provocare e far riflettere, di ironizzare e demistificare, attraverso la folgorante incisività del monologo e del dialogo. I primi quattro sono dialoghi di coppia o di famiglia che ironizzano riguardo le origini, le strategie, le interpretazioni e le soluzioni che si sono moltiplicate intorno alla pandemia da Covid 19. Gli altri quattro sono monologhi che dissacrano l’ossessione complottista, la solitudine esistenziale, la calamità della propaganda, l’apologia della verità. Ossia il falso e il vero messi a confronto nell’ambiguità di un Giano bifronte.
La seconda parte è uno scandaglio in profondità dentro un dittico di pura invenzione (Scacco all’isola e Mistero allo specchio, editi entrambi da Robin), in cui si mettono in scena una partita e una contropartita tra due donne, amiche per la pelle dall’infanzia, che si ritrovano sulle sponde opposte del crimine: una lo esercita, l’altra lo combatte. Spietate, diaboliche, ambiziose sono la perfetta antitesi delle vittime e delle eroine. Intimamente complementari tra loro una si dimena in una famiglia disastrata, l’altra fa giustizia della propria solitudine, una usa la perizia del proprio intuito, l’altra l’ingegno della propria arte. Ma non ci può essere una patta in questa sfida, solo tre possibili finali dal loro intrecciato destino.
 La terza parte infine è un omaggio all’ironia applicato a un tema che può essere terribilmente serio come irresistibilmente divertente: l’eros. Se ne può scrivere in tanti modi, qui si presentano alcune varianti in forma di decalogo polifonico, di parodia del trattato morale, di versi accorati e di duetti spiritosi, che fanno eco ai testi precedenti. Perché in fondo è tutta una questione di eros: sono coppie quelle dei dialoghi iniziali, si parla di amori impossibili in uno dei monologhi, Anna Tesei si rapporta a un marito arguto e imprevedibile, Emma Lamon uccide serialmente per passione. Ma soprattutto l’eros può mentire, dire la verità, stimolare l’invenzione e provocare l’ironia.
La terza parte infine è un omaggio all’ironia applicato a un tema che può essere terribilmente serio come irresistibilmente divertente: l’eros. Se ne può scrivere in tanti modi, qui si presentano alcune varianti in forma di decalogo polifonico, di parodia del trattato morale, di versi accorati e di duetti spiritosi, che fanno eco ai testi precedenti. Perché in fondo è tutta una questione di eros: sono coppie quelle dei dialoghi iniziali, si parla di amori impossibili in uno dei monologhi, Anna Tesei si rapporta a un marito arguto e imprevedibile, Emma Lamon uccide serialmente per passione. Ma soprattutto l’eros può mentire, dire la verità, stimolare l’invenzione e provocare l’ironia.




Commenti recenti